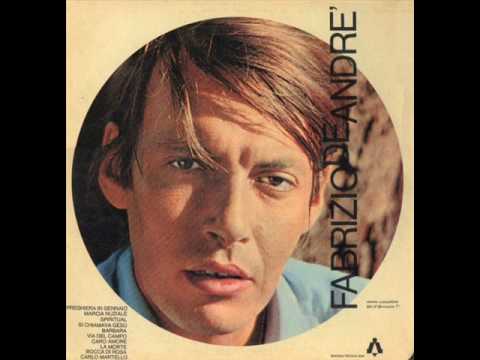Bocca di rosa

Richiesto da Anonimo
Pubblicato 18 agosto 2013
Ultima interpretazione 08 agosto 2021
Interventi 4 · Visualizzazioni 444 · Annotazioni 15
Come vedi questo sito cerca di non ospitare banner troppo invadenti (a parte la mia faccia!) e per sostenersi usa un banner nella parte superiore e i link affiliati.
Se vuoi supportare questo sito puoi acquistare alcuni di questi prodotti che ti consiglio perché li uso e/o mi sono stati utili
- L'era della Dopamina di Anna Lembke è una riflessione che individua le problematicità che derivano dall'uso dei media digitali e individua alcune possibili soluzioni e racconta nel dettaglio i meccanismi psicologici che permettono di produrre dopamina nei modi più inaspettati
- Deep Work di Cal Newport è una riflessione sulla concentrazione e sulla capacità di lavorare in modo profondo li Hosting su DigitalOcean
- Momento.cc la piattaforma per la gestione del tempo che abbiamo creato a lavoro e che usiamo ogni giorno per tenere traccia delle nostre attività e che aiuta a fornire il giusto valore al tuo tempo
Grazie per il tuo supporto!
Significato più votato
Caricamento dei sotto commenti in corso...
Caricamento dei sotto commenti in corso...
Caricamento dei sotto commenti in corso...
Caricamento dei sotto commenti in corso...
Altre canzoni di Fabrizio De Andrè
- La domenica delle salme 56 Commenti
- Canzone dell'amore perduto 17 Commenti
- Fiume Sand Creek 15 Commenti
- Andrea 14 Commenti
- Preghiera in gennaio 11 Commenti
Testo
La chiamavano Bocca Di Rosa
Metteva l'amore metteva l'amore
La chiamavano Bocca Di Rosa
Metteva l'amore sopra ogni cosa.
Appena scesa alla stazione
Del paesino di Sant'Ilario
Tutti si accorsero con uno sguardo
Che non si trattava di un missionario.
C'è chi l'amore lo fa per noia
Chi se lo sceglie per professione
Bocca Di Rosa nè l'uno nè l'altro
Lei lo faceva per passione.
Ma la passione spesso conduce
A soddisfare le proprie voglie
Senza indagare se il concupito
Ha il cuore libero oppure ha moglie.
E fu così che da un giorno all'altro
Bocca Di Rosa si tirò addosso
L'ira funesta delle cagnette
A cui aveva sottratto l'osso.
Ma le comari di un paesino
Non brillano certo d'iniziativa
Le contromisure fino al quel punto
Si limitavano all'invettiva.
Si sa che la gente da' buoni consigli
Sentendosi come Gesù nel tempio
Si sa che la gente da' buoni consigli
Se non può più dare il cattivo esempio.
Così una vecchia mai stata moglie
Senza più figli, senza più voglie
Si prese la briga e di certo il gusto
Di dare a tutte il consiglio giusto.
E rivolgendosi alle cornute
Le apostrofò con parole acute:
"Il furto d'amore sarà punito -disse-
Dall'ordine costituito".
E quelle andarono dal commissario
E dissero senza parafrasar:
"Quella schifosa ha già troppi clienti
Più di un consorzio alimentare".
E arrivarono quattro gendarmi
Con i pennacchi con i pennacchi
Ed arrivarono quattro gendarmi
Con i pennacchi e con le armi.
Spesso gli sbirri ed i carabinieri
Al proprio dovere vengono meno
Ma non quando sono in alta uniforme
E la accompagnarono al primo treno.
Alla stazione c'erano tutti
Dal commissario al sacrestano
Alla stazione c'erano tutti
Con gli occhi rossi e il cappello in mano.
A salutare chi per un poco
Senza pretese, senza pretese
A salutare chi per un poco
Portò l'amore nel paese.
C'era un cartello giallo
Con una scritta nera, diceva:
"Addio Bocca Di Rosa
Con te se ne parte la primavera".
Ma una notizia un po' originale
Non ha bisogno di alcun giornale
Come una freccia dall'arco scocca
Vola veloce di bocca in bocca.
E alla stazione successiva
Molta più gente di quando partiva
Chi manda un bacio, chi getta un fiore,
Chi si prenota per due ore.
Persino il parroco che non disprezza
Fra un miserere e un'estrema unzione
Il bene effimero della bellezza
La vuole accanto in processione.
E con la Vergine in prima fila
E Bocca Di Rosa poco lontano
Si porta a spasso per il paese
L'amore sacro e l'amor profano.
Come vedi questo sito cerca di non ospitare banner troppo invadenti (a parte la mia faccia!) e per sostenersi usa un banner nella parte superiore e i link affiliati.
Se vuoi supportare questo sito puoi acquistare alcuni di questi prodotti che ti consiglio perché li uso e/o mi sono stati utili
- L'era della Dopamina di Anna Lembke è una riflessione che individua le problematicità che derivano dall'uso dei media digitali e individua alcune possibili soluzioni e racconta nel dettaglio i meccanismi psicologici che permettono di produrre dopamina nei modi più inaspettati
- Deep Work di Cal Newport è una riflessione sulla concentrazione e sulla capacità di lavorare in modo profondo li Hosting su DigitalOcean
- Momento.cc la piattaforma per la gestione del tempo che abbiamo creato a lavoro e che usiamo ogni giorno per tenere traccia delle nostre attività e che aiuta a fornire il giusto valore al tuo tempo
Grazie per il tuo supporto!